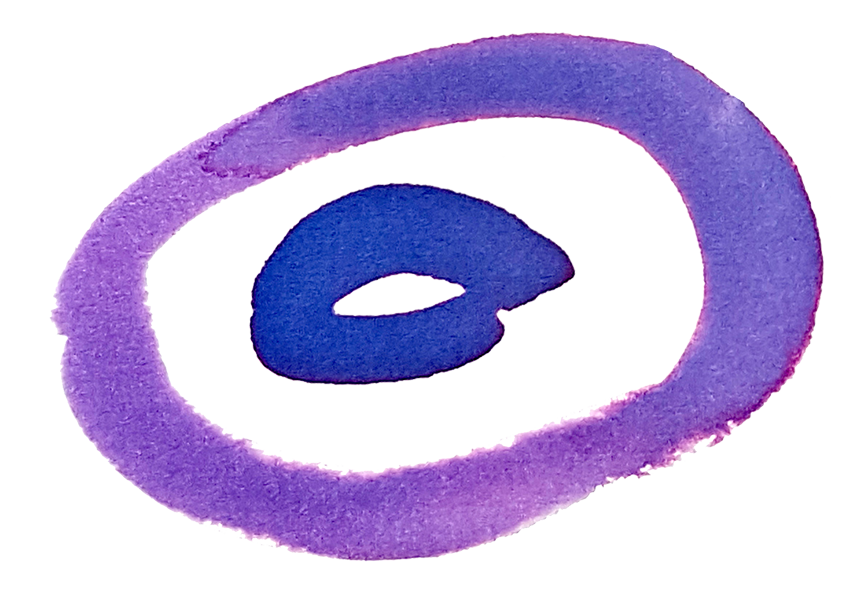La poetessa Giusi Quarenghi propone l’ascolto della parola poetica come un incontro dialogico che permette ad ognuno di maturare una più consapevole individuazione di sé, mentre nella seconda e più conversevole parte dell’intervista, racconta di esperienze nelle scuole e nei reparti di pediatria con la parola poetica che diventa strumento per prendersi cura e bonificare la qualità delle relazioni.
Manzalini: Nel pensare questo incontro la prima cosa che ci siamo chiesti è: quando la parola diventa poesia che cura?
Quarenghi: Per rispondere penso a quando e come io ho percepito come curante la parola poetica, che l’ascoltassi o la leggessi. Ne ho letto molta; soprattutto, ho cominciato leggendola.
Al di là di quello che dice, penso che la parola poetica abbia questa capacità di cura quando tu la ascolti e senti che quella parola ti ha già ascoltato, ti ha trovato o viene a cercarti; quei versi che stai leggendo li trovi come se ti aspettassero, e ti venissero vicino senza che tu avverta il minimo bisogno di difenderti, anzi. Parola che cura è quindi quella che riesce a entrare in relazione, a fare contatto, legame.
Bulfaro: Come se scaturisse l’idea che la parola si lascia interrogare. Tu la interroghi e le chiedi: “Cosa mi stai dicendo?“
Quarenghi: Questo, ma ancora prima del “Cosa mi stai dicendo” c’è la constatazione che “Stai parlando con me”; di fronte a questa parola che sento come rivolta a me, io ci sono.
Manzalini: Una sorta di riconoscimento, come se la parola mi permettesse – nell’incontro – di riconoscere che questa cosa è per me, la parola arriva per me.
Quarenghi: Sì, una sorta di riconoscimento, che sono e ho consistenza di fronte a quella parola. Come se mi desse realtà, chiedendomi ascolto; realtà e credito. Altrimenti scivolerebbe via.
Se penso al “fermo” che la lettura di alcuni versi mi provocava, già da ragazzina… era proprio questo, li sentivo diretti a me, mi interpellavano, e mi costringevano a fermarmi, su una parola, un pensiero, un sentimento, su qualcosa e dove prima non ero, e mi chiamava… “Viveva con sua madre in Cornovaglia/ un dì trasecolò nella boscaglia.” Così Pascoli inizia Breus… quel “trasecolò” aveva dentro tempo e spazio, un verbo solo li diceva bene tutti e due e io, avrò avuto nove anni, “trasecolai”, anch’io, con Morvàn là nella boscaglia… mi aveva portato dove desideravo essere, prima non lo sapevo. Ecco, “trasecolare nella boscaglia” fu l’inizio della meraviglia di ogni andare e incontrare…
Manzalini: L’altra cosa che a noi premeva ricavare da questo confronto è sapere qualcosa di più delle esperienze concrete che ti sono capitate, nelle quali hai potuto sperimentare questa azione di cura che la poesia, o meglio la parola poetica, può esercitare.
Quarenghi: Premetto che non c’è intendimento dichiarato di cura, non ho nessuna competenza per questo (se non il mio stesso aver sperimentato bisogno di cura, di riceverla e darla), e neppure mi chiamano per questo. A questi contesti (scuola, gruppi associativi, reparti pediatrici, carcere…), ho accesso in nome di una frequentazione e di una familiarità con il fare e il leggere poesia. E so che la poesia capovolge la nota legge di Murphy… se c’è una qualche possibilità che vada bene, lo farà. È meno probabile l’inverso, anche se non è escluso.
La pre-condizione “buona”, in questi contesti, è che si propone una circolarità, un patto di ascolto e di attenzione, essere attenti a qualcuno è dargli realtà (per Simone Weil l’attenzione è la forma più alta di generosità). Di fronte alla poesia, ci si dà realtà, reciprocamente, grazie a un terzo che non sono io, non sei tu, non è il gruppo, non è chi è presente, è la poesia, che ci fa essere tutti, e tutti lì, uno per uno e insieme, dentro quelle parole, accanto, di fronte ad esse, al loro cospetto. Come fa il mare con chi si tuffa. Siamo lì, dentro il mare e affidati al mare, all’acquaticità; allo stesso modo siamo dentro e affidati alle parole, fluide, liquide, scorrevoli, eppure consistenti, potenti, profonde. E, grazie a letture, racconti, parole, sortiscono altre parole, si compongono frasi, si trovano ritmi… e quel tempo insieme si fa buono, benefico, accoglie tiene e accompagna, e magari lascia anche una scia di luce, come l’arca di Noè.
Con questi contesti non voglio, come dire, prendere dimestichezza, confidenza, non ci vado d’abitudine; sono incontri rari, eccezionali, e io sono, ogni volta, in apprensione, non tranquilla; il mio eventuale sapere-come-si-fa ha senso solo se mi apre al “trasecolamento” che mi aspetta, e non me ne protegge. In questi contesti, penso soprattutto alle pediatrie e al carcere, è avvertibile uno spessore di fatiche, di messe alla prova, di resistenze, di difficoltà, di ferite, che io posso solo in parte e forse percepire e in qualche modo ospitare. Senza necessariamente metterle al centro; anzi, a volte, giova proprio fare in modo o lasciare che scivolino via e si appoggino per un po’ altrove, e magari poi, quando tornano e si riprendono, le si trova quasi come trasformate, o forse è avvenuta una piccola trasformazione in noi, e le guardiamo con un altro occhio.
Molto interessanti sono gli incontri con i volontari: ho tenuto, all’interno della loro formazione specifica, degli incontri di poesia, come forma di “manutenzione” dell’atteggiamento del volontario… Perché i chiaroscuri sono infiniti, in te, fuori di te e intorno a te; e la carica delle buone intenzioni e della motivazione non copre tutto, non basta, anzi a volte è troppa e troppo, e va tenuta d’occhio. Come sa fare la poesia, così capace di sguardo e di ascolto del dentro e del fuori, delle stanze buie, degli spazi con l’accesso difficile, dove tu stesso ti senti straniero, anche se si tratta pur sempre di te; aprire al segreto e al labirinto, di ognuno, di tante situazioni, e aprirsi, può essere di giovamento. La poesia sa muoversi nel buio, a volte fa da gibigiana, improvvisamente illumina un punto, una traiettoria, vedi cose di cui non sapevi, e polvere d’oro. Ne viene stupore e, allo stesso tempo, un più di consapevolezza, di percezione, di orientamento, e anche di prudenza, che porta a interrogarsi sulla misura, tra vicinanza e distanza, per esempio.
Se da questi incontri scaturisce e rimane desiderio di poesia, che diventerà magari familiarità, sarà come aver trovato qualcuno che può essere un buon compagno di strada. Leggere poesia continua a esercitare su di me un buon maternage, una custodia che sento concretamente.
Manzalini: Come un’azione di supporto, di rafforzamento, di prevenzione, mi verrebbe da chiamarla.
Quarenghi: Sì, e anche di resistenza e di resilienza. E anche di alleggerimento e di sorriso, a volte dissacratorio, capace di far cadere per terra quello che pretende di stare su, molto in alto… e capace di cogliere l’incanto delle minuzie, la grazia del niente di cui i giorni sono costellati, per cui non abbiamo né occhi né memoria. Ecco, la poesia coltiva uno sguardo alfabetizzato in questo senso, uno sguardo che la riconosce, questa grazia del poco, la considera, la rende degna voce del bilancio. Quanta bella energia.
Manzalini: Ma ci sono dei messaggi? Per dirla con un’espressione di Tognolini, che peraltro ha citato l’esperienza di Giusi Quarenghi come una voce particolare attenta ai piccoli, diremmo dei “messaggi pilota”. In questa poesia dedicata ci sono dei messaggi precisi o è tutto fondato sull’ascolto e quindi sul riconoscimento?
Quarenghi: La domanda è chiara e chiaramente rispondo che rifuggo dall’idea di “messaggio”. Cioè, mi piace questa attenzione declinata sulle cose: gesti, oggetti, suoni, odori, colori dell’aria, volti, voci… Mi piace quella che chiamavo “grazia”, del poco, del senza credito. Me l’ha insegnato, credo, la pratica della lettura. Se non avessi trovato rifugio e fuga nella lettura, nella mia infanzia in montagna, in anni ancora senza televisione, e nella mia adolescenza in collegio, non so come avrebbe potuto andare… Pensando ad allora, al poi, e anche in relazione ai tempi che corrono, dico con Woody Allen: «Leggo per legittima difesa».
Quanto ai messaggi, se ne trovi, l’autore sei tu. La letteratura in generale e in particolare la poesia non lanciano messaggi, se non quelli che trovi tu e tu stesso ti mandi. Poi, magari vai a vedere il nome del poeta da cui provengono e magari non l’hai mai sentito, o mai letto; sconosciuti l’uno all’altro, è stupefacente che la sua poesia abbia posto anche per te. Tutto questo ha qualcosa di divino, davvero credo che abbia a che fare con l’esperienza del divino.
Bulfaro: Questa risposta integra il discorso della necessità di avere una consuetudine di relazione con la poesia, consuetudine che tu cercavi di portare nella formazione di questi volontari.
Manzalini: sì, ritornando alla formazione dei volontari, la poesia diventa un’educazione all’ascolto, al riconoscimento, a usare la parola come elemento che dà alle persone struttura; mi verrebbe da dire anche dignità, in un certo senso.
Quarenghi: Sono d’accordo. La parola che viene detta e la parola che viene taciuta. L’attenzione va data a quello che può essere detto, a volte forzando anche, per andare un po’ più in là, un po’ oltre. A volte, invece, c’è una parola trattenuta che va capita; a volte occorre capire che una parola, che quella parola va trattenuta, lasciando un vuoto, o cercandone un’altra. La parola in senso totale e profondo. Quella che dici tu e quella che ricevi, come parli e come ascolti, e come vedi l’altro dire e ascoltare, perché, in come si dice si ascolta e ci si vede ascoltati o meno, si raccoglie, si svela/vela una completezza d’essere, per cui anche il come sei seduto o in piedi, come ti muovi o stai fermo, se e come mi guardi o distogli lo sguardo, diventano significanti, insieme alle parole e ai silenzi.
Manzalini: Ci sono due cose che ascoltando mi preme sottolineare: la parola poetica cura, ma d’altro canto forse dobbiamo anche cogliere che ci sono bisogni molteplici. Perché per esempio in pediatria c’è sì un bimbo affetto da una patologia, ma ci sono anche i suoi genitori, ci sono i volontari e poi lo stesso personale del reparto ha dei bisogni. Quindi, la parola diventa occasione di cura per tante situazioni di sofferenza e dobbiamo pensare alla poesia come azione curativa in tante direzioni.
Quarenghi: Penso proprio di sì e ancora prima che “curare”, conta, almeno “non nocére” (regola della scuola salernitana, che vale sempre e ovunque, in ogni gesto che si pretende/propone come curativo). La consuetudine con la poesia può giovare al parlare, dico al parlare in genere, in quanto può rendere sensibili e attenti a questo parlare in genere, nostro e degli altri, per fare in modo che non diventi un parlare generico. Un parlare che sia in grado di tenere insieme rispetto e chiarezza: la chiarezza di quello che è da dire, il rispetto della persona a cui lo si dice e della sua situazione, per riuscire a raggiungerla davvero, senza nulla togliere al vero, e andandole vicino nella misura giusta, che giova se può e non fa danno. Vale sempre con chi è in condizione di fragilità, minorità, sofferenza. Come si parla/si tace traduce/tradisce l’intensità e la qualità della presa in carico.
Bulfaro: Volevo aggiungere sul discorso della consuetudine con la poesia che in realtà poi aumenta anche il grado di ascolto. È come se ci fosse in quest’azione continua di bonifica la qualità del tuo ascolto: ascolto della parola, ascolto dell’altro. Se questa qualità aumenta, aumenta anche il grado di risonanza che le parole poetiche hanno in te e anche la risonanza dell’altro in te e quindi aumenta anche l’empatia. C’è tutto un lavoro che viene da sé una volta che c’è questa consuetudine della poesia.
Quarenghi: Se la frequenti poeticamente, anche la parola più immediata e più semplice apre e amplifica il campo semantico, si apre, in chi la dice e in chi l’ascolta; la parola diventa profonda e si allarga, a fisarmonica. Questa familiarità poetica è, come dicevi tu, una sorta di bonifica dell’esprimersi e del comunicare, la doppia valenza del linguaggio. Da parte di chi parla, di chi ascolta, nello scambio dialogico, nella discussione di gruppo. E vale sempre, non solo nel laboratorio poetico! Vale nella e per la quotidianità, in tutti i suoi momenti: dal pasto alle terapie, dalle questioni igieniche allo scambio con i parenti. Il set clinico ha molti aspetti, quanti curativi e benefici, quanti iatrogeni… quanto potere di male dentro comunicazioni improprie, inadeguate che dicono senza minimamente porsi il problema del quando, del chi e del come. O in silenzi imposti e indifferenti, semplicemente perché il carico di quello che andrebbe comunicato è pesante. Non è semplice. Ma quelli il cui compito è “curare”, o “formare”, o “insegnare”, o “educare” andrebbero formati anche su questo.
Manzalini: Sta tornando a più riprese, ma era una delle domande che noi avevamo messo in conto di fare. Poco fa si faceva riferimento all’effetto iatrogeno nella parola. A volte le parole possono creare danno involontariamente (perché l’azione iatrogena non è volontaria, è involontaria, evidentemente) ma ci deve essere un’attenzione particolare alle controindicazioni? Insomma, ci chiedevamo se bisogna avere delle paure o delle preoccupazioni particolari nell’usare la parola. C’è una preoccupazione particolare che il poeta deve avere?
Bulfaro: C’è un passaggio collegato a questo, così almeno do un altro spunto in più. Dal capitolo Di più temo la luce, c’è un testo che dice: “Ho mandato il tuo corpo a memoria/ ripasso le frasi della tua pelle/ le virgole delle tue ossa/ i punti dove si fermano i piedi/ si appoggiano i fianchi/ faccio scorta della curva delle orecchie/ del tondo delle unghie/ d’ogni piega d’odore/ del ti tocco e del mi tocchi/ che tu mi manchi/ è il mio ultimo amore.” C’è anche questo timore?
Quarenghi: Tu dici timore, lui ha detto paura, io aggiungo preoccupazione. Quando entri in certi territori, cominci con l’apprensione e arrivi all’angoscia. Però credo anche di poter dire che, fatto il giro nel labirinto del buio, se non ti sottrai, senti che ne scaturisce una forma che può prendere corpo nella parola. E lì lasciare traccia; e ricucire follie, disinnescare ansie, trattenere dai precipizi, anche solo momentaneamente rimagliare, andare oltre, anche per poco. E ti rimane come possibilità, perché possibile è stato, lo sai, l’hai provato. Quella forma, che tu adesso mi hai restituito leggendola, io so bene da dove mi è venuta, ma so anche, in nome della forma che ha trovato, che sento che non mi riguarda più in modo esclusivo. Non a caso è in un libro.
Bulfaro: È congedata.
Quarenghi: una tenda aperta, una stanza che ho attraversato e di cui ho potuto buttare la chiave, lasciando la porta socchiusa… entri ed esca chi vuole. “I versi sono esperienze”, ha scritto Rilke. Esperienze, non “emozioni”, e lo dico non senza polemica con il generico parlare contemporaneo. Fare dell’esperienza parola e esperienza della parola, con i rischi del dire e del non dire, e con la lezione del ritmo poetico, della pausazione, del respiro che amministra e ordina, disegna, in un certo senso, il magma, il caos da cui si rischia di essere sommersi.
Bulfaro: Però mi hai acceso una cosa sulla quale forse non mi ero mai soffermato: effettivamente quel “leggere secondo una misura” o comporre secondo la misura, in realtà, ti insegna a dare misura senza contenere o senza evadere. Dare misura a un vuoto, a una mancanza, a qualcosa con cui effettivamente bisogna rapportarsi: e quindi si può imparare a gestirlo.
Quarenghi: Hai detto bene, sono d’accordo. In qualche modo ne fa una partitura.
Manzalini: Scusate, voi usate il linguaggio, la conoscenza e la competenza poetica, io ragiono con le mie categorie da medico: a me ha colpito molto il riferimento al respiro. Il respiro è il sistema autoregolatorio più potente rispetto al mondo interiore, quello che va in automatico. Rispetto ai movimenti interiori dei sentimenti delle emozioni, che sono spontanei, l’unica possibilità che noi abbiamo di starci dentro e quindi farci i conti e anche un po’ regolarli, perché non diventino troppo, è proprio il respiro. Quindi anche a me ha colpito questo legame che c’è.
Bulfaro: Infatti quell’andare a capo che ti dà il respiro…
Manzalini: … e che ti costringe alla pausa…
Bulfaro: … ti porta a dare questa misura, ancora una volta, non sola la misura all’interno del verso, ma è proprio la misura respiratoria.
Quarenghi: A proposito di misura, di grafica della misura, a suo tempo mi ero innamorata dei trattini della Dickinson… bisogna pure, ed è così bello, fare degli omaggi, avere gratitudini, scegliere affiliazioni. Poi i trattini li ho abbandonati, ma non la pausa lunga, il respiro che stacca e fa spazio tra le parole anche all’interno del singolo verso: questo fa succedere qualcosa. Antonio Porta dice della “oscillazione di senso” generato dall’andare a capo, lì avviene poesia. Credo valga anche per gli spazi bianchi: aprono le parole, ne variano la temperatura, riprendono l’intonazione, spezzano l’associazione automatica…
Bulfaro: E poi, rispetto a quello che dicevi, che la poesia vive delle parole dette e delle parole non dette, se penso ai bianchi di Ungaretti non sono all’interno del verso, ma in realtà proprio spazi che danno spazio alla parola non detta, che costruiscono tutta un’altra misura di riattacco alla strofa successiva, potente. Anche nel tuo verso, nel leggerla ho sentito che la poesia, appunto, sta in realtà anche tra le parole, in quegli spazi, però tu dilatandoli un po’, non dando solo una battitura, magari sono due o tre battiture, ti mostra dove sta anche la poesia, o forse soprattutto la poesia, non in quel “tra le parole”.
Quarenghi: Tu notavi il respiro: ma il respiro è legame, relazione: non c’è se non c’è l’aria, e l’aria è fuori, dentro fuori dentro fuori, questo è il movimento. Il respiro però è assolutamente soggettivo. A volte si spezza, a volte proprio non viene. Dipende dal dentro, dipende dal fuori? Spesso le cose sono interdipendenti; ma l’aria, questo bene comune, primario, gratuito, hai d’averla intorno. Eppure succede, a volte, che attorno l’aria ci sia ma tu non riesci a respirare…
Manzalini: Stavo collegando le parole: le parole che ci individuano, l’aria come le parole, a volte le parole ci sono ma noi non siamo capaci di riconoscerne la potenza…
Quarenghi: Oppure te ne difendi…
Manzalini: … perché fanno paura…
Quarenghi: …. perché vuoi starne al di qua. Eppure alle parole ti consegni! Possono anche mascherarti le parole, certo. Ma ogni maschera è allo stesso tempo anche smascheramento. Dimmi la tua maschera e ti dirò chi sei.
Manzalini: Ho colto nella narrazione il riferimento biografico “da bambina leggevo, anche perché non avevo altro…”. Mi chiedevo: oggi le parole viaggiano veloci come viaggia veloce il nostro tempo; c’è qualche indicazione, qualche accortezza, basata anche sull’esperienza diretta con i bambini, per aiutare a quella consapevolezza, a quella dimestichezza, a quella padronanza di cui parlavamo prima? Perché io credo che questa sia un’azione di cura: nei vari passaggi della vita incontriamo dei momenti nei quali la parola è di fondamentale importanza, ma se non siamo stati in qualche modo aiutati, educati… Per non usare la parola con pressappochismo, oppure con una velocità che diventa superficialità: ci sono delle attenzioni particolari per le giovanissime generazioni?
Quarenghi: I miei incontri con gli adulti, genitori e insegnanti, anche del nido e delle materne, hanno spesso a che fare, appunto, con la poesia. Il primo incontro o la prima parte dell’incontro lo dedico all’atto dovuto, alto, riconosciuto, dell’attenzione e dell’ascolto. Fin da quando sono piccolissimi, fin da quando cominciano… è un periodo sorprendente, miracoloso quello di quando i piccoli montano, smontano, impastano le sillabe, i suoni, coniugano gli aggettivi, declinano gli avverbi perché bene come è e come si fa ancora non lo sanno, ma vogliono dire e non desistono… Danno nomi con suoni capaci di nominare tratti segreti delle cose, da loro però visti, percepiti, sperimentati e/o fantasticati. Vogliono dire e parlano di quello che sanno, di quello che fanno, di quello che toccano e che li tocca, e lo fanno grazie alla raccolta di suoni che hanno ascoltato e “pizzicato” in giro. Lo vedi e lo senti bollire quello che poi diventerà il fiume di lava che uscirà dal vulcano. Le ninne nanne, i nomi, i gesti, le espressioni, i versi, gli sguardi… ma quando cominciano a dire, hai veramente la percezione di essere di fronte a un miracolo che si ripete. Quante volte questi piccoli, così ingegnosi e intenti a “smagmare”, se così posso dire, i suoni e i significati, quello che vogliono dire con quello che possono dire, hanno episodi, periodi di balbuzie. E quante volte gli adulti, genitori e maestre, per proteggerli e toglierli da quella che vivono come una difficoltà, gli prendono la parola o la frase e la finiscono, la dicono al posto loro, filata e completa. Io credo che non andrebbe fatto. C’è tempo, e con i piccoli bisogna sempre prendersi il tempo necessario ad avere tempo, tutto quello che ci vuole!! Pazienza, c’è tanto pensiero e ci sono tanti pensieri, il bambino è attento a tante cose insieme, però sulla punta della lingua devono mettersi in fila sillabe e parole, una per volta. Ma è un lavoro suo! Pazienza. Prendiamoci il tempo di dar loro tempo, lo ripeto, troviamo l’attenzione alla loro misura, rispetto per il loro modo. E parliamo “bene” con i bambini, e “bene” ascoltiamoli, e diciamo “bene” le cose della quotidianità, curiamo la qualità quotidiana del nostro parlare con i bambini delle cose quotidiane: il silenzio, la disciplina, a tavola, nell’intervallo, a lezione, sul serio, per gioco e nel gioco. E direi anche di non trascurare, soprattutto per chi fa l’insegnante, l’educazione alla vocalità, una buona ed efficace gestione della voce.
Bulfaro: Perché tra l’altro è uno dei problemi in cui incorrono più spesso.
Quarenghi: È la loro materia prima, il loro strumento per ore e ore. La tua voce è la tua marcatura personale, la tua risorsa, lo strumento che porti sempre con te, che ti porta fuori di te, che ti mette in relazione. “La voce è il muscolo dell’anima”, ha scritto Corrado Bologna. Ci sono voci con morbidezze invidiabili, belle pastosità; ma spesso le voci sono faticose, escono da gole affaticate e arrivano alle orecchie spiacevoli da ascoltare.
Manzalini: Però qui l’attenzione alla parola diventa di nuovo cura. Sto pensando, con una battuta, che la parola cura le corde vocali degli insegnanti. Si potrebbero risparmiare.
Quarenghi: E contemporaneamente la convivenza di classe, e persino la disciplina, quanto se ne avvantaggerebbero. Da tempo ci siamo abituati a mangiare con la televisione accesa, a convivere con il sottofondo, con una colonna che faccio fatica a chiamare sonora, dato che a mio parere è piuttosto un ammasso di rumori a vario volume. In classe si vive mediamente nel brusio, abituati a una confusione che tende a superare la soglia della sopportabilità. È così, ma non è né obbligatorio né inevitabile. E il quotidiano è importante e conta, influenza e condiziona. I bambini poi sono molto portati ad adeguarsi all’aria che tira e a collaborare. E hanno anche una soglia di attenzione molto più alta di quella degli adulti, di questo sono sicura, e riescono a prestare attenzione a più d’una cosa in contemporanea!
Parlare della parola non vuol dire tralasciare le immagini, che sono dappertutto, come il rumore, una massa e un ammasso che possono essere molto aggressivi, soprattutto se lasciamo che ci piovano addosso e basta. Anche le immagini hanno bisogno di essere lette, imparare a leggerle è necessario. Per fortuna ci sono i libri illustrati, quelli belli soprattutto, a loro modo poesia, con le parole ma anche senza, i cosidetti silent book dove, prima di tutto, ti perdi, “trasecoli”. La riga delle parole ha una direzione e un senso, riconosci subito dove comincia e verso dove va. L’immagine comincia… ma l’immagine comincia? L’immagine la vedi tutta, le caschi dentro. O forse comincia dove io comincio a guardarla, o forse è disegnata in modo che io incominci a guardarla da lì… Tutto questo è allo stesso tempo spaesamento e mappatura. E quanti fili, quante storie possono portare avanti insieme certi libri illustrati, con il ditino dei bambini che le trovano e le inseguono, perdendole e ritrovandole, perdendosi e ritrovandosi; e, quante parole, grazie a quelle non parole che pure ci sono! Quanto riconoscere e quanto inventare! E le immagini trattengono e restituiscono, a modo loro, quel dire e quell’immaginare, le storie del libro e le loro, che si mescolano e si muovono, si modificano, e se ne aggiungono altre, perché i giorni hanno le loro sorprese, e gli umori cambiano e le parole trovano posto, fanno posto a quello che succede, a quello che può voler dire quello che succede. E non sono buoni solo per i piccoli, gli album illustrati. Sanno stare anche nelle mani dei più grandi, si lasciano aprire anche da loro, e li aprono, li raggiungono…
Manzalini: Io li porterei anche alle superiori i libri illustrati.
Quarenghi: Sì, sì. Grande letteratura e libri illustrati!
Bulfaro: Da qualche anno si parla di iconodulia, termine che indica che questa è l’epoca del dolore, dovuto a una iperesposizione all’immagine. Però in realtà, emerge anche da quanto stiamo dicendo, più che libera esposizione all’immagine, che certo c’è, c’è il deficit di educazione all’immagine, educazione alla lettura dell’immagine, alla rielaborazione dell’immagine. È da lì che viene fuori poi appunto questo continuo buttare fuori immagini, ma perché non c’è un processo in realtà di rielaborazione, di vera relazione con l’immagine. È proprio lì che manca un punto su cui si dovrebbe fare un lavoro di compensazione.
Quarenghi: Davvero. E il cammino è molto lungo, perché non è ancora considerato, potrei dire, atto dovuto. L’alfabetizzazione può non comprendere l’immagine; per quanto si parli anche di educazione all’immagine, nella formazione degli insegnanti non ha gran posto, a meno di una forte motivazione e interesse personali. Tragicamente il sapere poco o nulla, però, si traduce facilmente, lo sappiamo bene, in un sapere qualunque. “Disegnate quello che volete” è la consegna più stupida, inutile e subdola che ci possa essere, non fa altro che anti-poeticamente favorire lo stereotipo. Mentre ciò su cui la poesia invece salta è proprio la rottura dello stereotipo, il disinnesco delle associazioni automatiche. Altrimenti, offri solo terreni che si imbevono di quello che viene giù, non fanno altro che subire la forza di gravità. Di quello che viene giù, e loro sotto.
Bulfaro: Prima hai utilizzato dei termini sulla poesia che rimandavano molto a una sorta di angelo custode mariano, per come l’avevi mixato, perché hai parlato sia della dimensione del maternage sia della dimensione del custodire.
Quarenghi: L’angelo necessario.
Bulfaro: Allora prendiamo da Ascolta. Salmi per voci piccole il componimento Dammi la mano, perché la poesia di per sé può dare la mano, può avere questo ruolo. Io ti lancio questo stimolo e poi tu vai: “Quando ti chiamo rispondimi/ Quando grido ascoltami/ sto gridando perché non mi senti?/ Sono io, non conosci la mia voce?…” Quel dammi la mano è un’invocazione a chi?
Quarenghi: A un “tu”! Potrei dire a un “tu necessario”, che abbia forma angelica o no… io poi non ho un’opinione pessima del male, come dire qualcosa che fa male ogni tanto può non essere sempre e solo un danno. Come dire, anche il negativo ha diritto a fare i suoi passaggi e avere un po’ di spazio. Insomma: la luce senza il buio sarebbe una tortura, di fatto.
Bulfaro: Posso fare una domanda provocatoria? Quindi, anche il paradiso è una tortura?
Quarenghi: «Nessuno che manca è il paradiso», dice una mia poesia. Forse il paradiso è stato usato come una promessa torturante. Ma che promettente paradiso in terra è il non-inferno di Calvino, alla fine de Le città invisibili: «L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.» Cercare qui ciò che non è inferno, e fargli spazio e coltivarlo. Riconoscere chi e cosa è non inferno, qui: questo è Paradiso. Questo “tu” poi, secondo me, è veramente una delle chiavi… dicevi prima dell’angelo, io ho nominato il divino; “curare” ruota attorno al senso dell’altro, comporta un senso profondo del “tu”, rivolge e conduce verso il fuori e l’altro da sé. Di solo “io” si implode; invece il “tu” porta fuori, mi porta a un “fuori di me” che è bello dire con le parole “intimior intimo meo”, è il tu che fa l’io, che mi fa “io”. I piccoli imparano a dire “io quando sono capaci di dire “tu”. “Io” e “tu” nascono insieme. Questo “tu” che imparo a dire apre all’idea e all’esperienza dell’alterità, da quella prossima, vicina a mia misura, a quella che mi eccede e trascende, penso all’immensità del “tu” della natura, che si declina con infiniti nomi e infinite forme creaturali, dalle quali non escludo neppure le pietre.
Credo che la poesia sia relazione e dialogo; credo che sia, di fatto, assumere il “tu” nella sua pluralità, perennità e vastità: rispetto all’esistere e al morire, di ogni creatura, a tutto quello che dentro l’esistenza avviene, in tutto ciò che rallegra e dà gioia, e in tutto ciò che fa desiderare di non esser nati, e rende testimoni di cose mai volute e impossibili da accettare.
La poesia porta fuori il dentro e dentro il fuori, li mette in relazione e in comunicazione. È dove ognuno di noi può essere un tu, e sentirsi tu, e dove ognuno può trovare un tu; cercare e essere cercati, andare verso, vicino, lasciare avvicinare; percepire che io e tu consuonano; alzare gli occhi, guardare più in là e vedere, o accettare di non vedere, o sapere di aver visto anche se non si voleva; avere sguardi per le creature e per le cose di questo mondo e dei mondi possibili. In questo incontro di alterità, i significati si ampliano, le esperienze svelano significati, si esce da sé e si ritorna a sé in altro modo, forse modificati.
Bulfaro: Possiamo dire che è anche un’altra modalità di ridimensionamento dell’ io? Perché prima abbiamo parlato di dettatura di una misura, di insegnamento di una misura e di una gestione nelle orizzontalità, ma in realtà vedendo anche queste immagini di questo “tu” e “io” che nascono insieme, hanno la stessa dimensione e poi con questo io che diventa ipertrofico, giganteggia, la poesia ti aiuta a ritrovare una dimensione dialogica. Dove effettivamente nel dialogo non c’è uno che prevarica sull’altro. Parte dall’ascolto, dall’ascolto dell’altro. Effettivamente in questo senso la poesia può essere uno strumento di ridimensionamento.
Tutta questa tua riflessione mi ha acceso anche l’idea che questo io cresce perché c’è una struttura e una dimensione del rapporto familiare. Nel senso che il bambino che fa nascere questo io-tu insieme poi si confronta con dei modelli sociologici che si sono modificati progressivamente. Soprattutto negli ultimi trenta anni, e io l’ho vissuto in prima persona, perché la mia era già la prima generazione, nella quale il bambino cominciava a diventare il sole della famiglia, spodestando quello che era invece il padre. Cioè mentre in una struttura sociale tradizionale agricola il padre, che era il capofamiglia e quindi in quanto capofamiglia, aveva anche addirittura diritto di mangiare più degli altri, aveva una serie di privilegi, era lui il centro, in una struttura così patriarcale diventava il sole della famiglia e tutto il resto doveva ruotare intorno a lui, con la trasformazione sociale e lo spostamento del ruolo di sole sui figli, effettivamente poi per il figlio, una volta che esci dal nucleo familiare e non sei più il sole, devi trovare un modo per ricollocarti nel mondo, senza avere un “io” così gigantesco perché poi una volta che esce dal nucleo familiare sei uno dei tanti.
Quarenghi: Il ruolo solare peraltro è faticosissimo, è un carico enorme, spesso eccessivo.
Bulfaro: Forse avevo sempre sottovalutato questo ruolo della poesia e adesso parlando con te, effettivamente mi hai illuminato.
Manzalini: Volevo provare anche io a sottolineare un aspetto molto interessante in riferimento a questa dimensione dialogica. Per definire noi, dicevamo all’inizio, e per star bene con noi (pensando a una funzione curativa) abbiamo bisogno di qualcosa che viene dall’esterno. Quindi questo continuo rimando, questo dialogo, questa dinamica… Pensavo a quanto mi ha colpito una tua raccolta, E sulle case il cielo che porta già nel titolo questo aspetto: se la casa diventa il luogo della nostra chiamiamola “identità”, o del tentativo di definirci in una nostra identità, però non possiamo definirci se non c’è un cielo, se non c’è altro. E quindi questa zona di confine, dove le case smettono dove c’è il cielo, ma nel contempo il cielo arriva fin dove sono le case. Mi piace molto questa dinamica che implica anche un po’ l’altro aspetto interessantissimo di questo libro, perché rimanda a un mio taglio di lettura: la presenza di bisogni molteplici. Ci sono i bisogni dei bambini, ma i bisogni dei bambini fanno emergere i bisogni dei grandi, evidentemente. E quindi mi incuriosiva la provocazione di Domenico che dice “Ma allora cos’è il paradiso? È una tortura?” Forse il paradiso è il nostro bisogno di completezza, che ci rimanda ad altro e forse mi veniva da sintetizzare che anche la poesia è paradiso, perché se la parola entra, ci rigenera, la parola entra a far decantare, ma ci riapre delle sfide di resurrezione forse possiamo…
Bulfaro: … però dentro ha anche il Male.
Quarenghi: Trema, forse ha paura, ma non si sottrae, e porta i segni. Pensa a Primo Levi. Ha consegnato all’umanità, a noi, un marchio a fuoco. È stato prescelto? È riuscito a essere, a stare all’altezza dell’impossibile, a individuarne la valenza, a leggerne la “reazione”? Com’è lo sguardo di chi riesce a stare dentro il buio? Come si legano in lui luce e buio? Forse perché la luce sia e si dia bisogna che il buio abbia e faccia la sua parte? Qualcuno dice che il Satan non è altro che una delle altre facce di Dio. Non a caso nei dettagli stanno sia l’uno sia l’altro, litigando ma anche giocando. Questo sguardo che non si sottrae, che tiene, che va oltre, e tiene, e ha da dire e dice; si spegnerà lo sguardo, ma non la sua capacità di aver visto e detto. Questo il fuoco che ha acceso Primo Levi, irraggiungibile lui da noi; ma lui ci ha raggiunto.
La poesia ha le spalle larghe e può reggere anche i fraintendimenti, vero, e più di tanto forse non se ne cura; quante volte sopporta di essere risciacquata in acquette sbrodolanti sentimentalismo, sfoghi emotivi, buonismi generici.
Ma quante volte ha avuto/ha segmenti, versi che sono folgori, folgori che mappano e sconvolgono il senso del mondo e dell’uomo, nel corso della sua storia, in quello che è stato e in quello che può essere. Per cui, nonostante tutto, vale tenersi, senza recedere, a quello che Bloch chiama il principio speranza. Non è sentimentalismo, la speranza, è condizione ontologica per essere vivi, ed è dovuta, la dobbiamo, alle generazioni più piccole, a chi cresce, a chi è in sofferenza. La speranza è capace di cura, e di tenerezza, come la poesia, quella che non teme di riconoscere, sapere e attraversare (anche) la disperazione.

Dome Bulfaro (1971) poeta, performer, artista visivo, editore, docente di Poesiaterapia e formatore, si dedica alla poesia (di cui si sente un servitore) e all’arte ogni giorno dell’anno. È uno degli autori italiani più attivi e decisivi nel divulgare e promuovere la poesia performativa ed è il principale divulgatore in Italia della Poetry Therapy/Poesiaterapia.
Ha fondato ed è direttore di Poetry Therapy Italia (2020), rivista di riferimento della Poesiaterapia italiana. Ha fondato e dirige (con Simona Cesana) PoesiaPresente – Scuola di Poesia (2020, Monza), prima scuola italiana di poesia performativa, scrittura poetica e poesiaterapia, prima in Italia a proporre corsi di formazione per Facilitatori/ici in Poesiaterapia.
Dal settembre del 2024 fa parte del board del Journal of Poetry Therapy (USA); nell’ottobre 2024 ha preso parte alla 1st European Biblio/Poetry Therapy conference 2024 (Budapest) come referente per la Poesiaterapia italiana.
(Foto Giuseppe Ruscigno)
» La sua scheda personale.
 Paolo Maria Manzalini (Napoli 1963) medico, psicologo clinico, psicoterapeuta si occupa di cura e riabilitazione psichiatrica dal 1992, prima in contesti residenziali e da dieci anni in contesti territoriali. Attualmente Responsabile della Struttura Semplice dell’Area Territoriale Psichiatrica della ASST di Vimercate. Promotore con l’Equipe del CPS di Vimercate della rassegna Far Rumore – Azioni per la salute mentale. Da sempre attento alla parola come fondamento dell’incontro e della comunicazione tra gli umani, negli ultimi cinque anni ha ripreso ad approfondire l’espressione teatrale e ha preso parte alla edizione 2017-18 del Corso di TeatroPoesia condotto da Domenico Bulfaro presso il Teatro Binario 7 di Monza. Responsabile Comitato Scientifico di Lì sei vero – Festival Nazionale di Teatro e Disabilità.
Paolo Maria Manzalini (Napoli 1963) medico, psicologo clinico, psicoterapeuta si occupa di cura e riabilitazione psichiatrica dal 1992, prima in contesti residenziali e da dieci anni in contesti territoriali. Attualmente Responsabile della Struttura Semplice dell’Area Territoriale Psichiatrica della ASST di Vimercate. Promotore con l’Equipe del CPS di Vimercate della rassegna Far Rumore – Azioni per la salute mentale. Da sempre attento alla parola come fondamento dell’incontro e della comunicazione tra gli umani, negli ultimi cinque anni ha ripreso ad approfondire l’espressione teatrale e ha preso parte alla edizione 2017-18 del Corso di TeatroPoesia condotto da Domenico Bulfaro presso il Teatro Binario 7 di Monza. Responsabile Comitato Scientifico di Lì sei vero – Festival Nazionale di Teatro e Disabilità.
» La sua scheda personale.