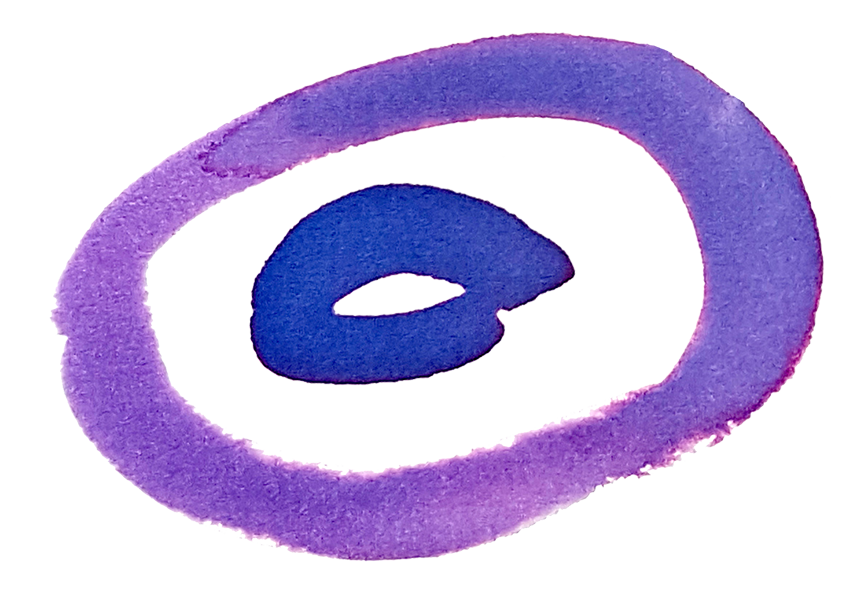Esperienza di un laboratorio di poesia con adolescenti ricoverati per disturbi del comportamento alimentare
A fine aprile 2015, insieme a Valerio Grutt, sono entrata all’interno del Centro per i disturbi del comportamento alimentare del Policlinico di Sant’Orsola. Nell’ambito del progetto “Le parole necessarie” organizzato dall’Ospedale e dal Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, abbiamo sperimentato un laboratorio di scrittura poetica con le ragazze ricoverate in reparto. Dovevano essere tre soli incontri, sarebbero diventate sette settimane.
Da anni tenevo laboratori di poesia nelle scuole superiori, ma l’incontro con queste ragazze, quasi tutte preadolescenti, mi ha messa di fronte al potenziale del metodo che andavo perfezionando; ho capito che la poesia poteva agire a un altro livello nella vita delle persone. Il testo che segue è l’abstract inedito che ha attirato l’attenzione di Mondadori sul mio lavoro. Dopo aver letto queste pagine gli editor responsabili della “varia” mi hanno chiesto di scrivere il libro Domare il drago, in cui sono racchiusi il mio metodo e le storie di tanti ragazzi che attraverso la poesia hanno trovato una strada di conoscenza e trasformazione.
Attraversiamo con il cuore in gola il corridoio vuoto, i volontari del reparto ci accompagnano nella piccola sala e cominciano a disporre le sedie intorno al grande tavolo. La prima ad arrivare è una bambina: «Scusate se mi presento in pigiama ma ho il raffreddore» dice porgendoci formalmente la mano come una piccola signora che gioca all’ora del tè. Sarà seduta al mio fianco per tutto il percorso, D., undici anni, quella che saprà dire le cose più dure e incantarci con l’ironia.
Credevamo di trovarci di fronte a delle ragazze, e invece quel giorno erano nove bambine, quasi tutte tra gli undici e i quattordici anni, solo due ragazzine un po’ più grandi.
Alcune di loro saranno dimesse prima della fine del percorso, altri arriveranno a laboratorio iniziato. Nel corso del nostro laboratorio lavoreremo con 13 ragazzi in età compresa tra i dieci e i diciassette anni.
«Credevamo che i poeti fossero vecchi con la barba che raccontano storie noiose – dice D. – come il mago che anziché fare trucchi si è messo a parlare, e si è pure messo a piangere». Ridono tutte, essere meglio del mago è il nostro primo obiettivo raggiunto.
Iniziamo leggendo qualche nostra poesia, raccontando la nostra adolescenza. Nel mio metodo la prima lezione è un affidarsi: io affido per prima cosa il mio segreto, prima che i ragazzi mi mettano tra le mani il proprio. Leggo poesie che parlano dell’amore non corrisposto, dell’ora di ginnastica alle medie e di quelli che non vengono mai scelti. Metto con serietà la mia vita nelle loro piccole mani. La poesia con cui alla fine vedo cambiare il loro sguardo parla di una giovinezza felice che arriva fuori tempo, come un fuoco d’artificio a mezzogiorno. Dico loro che non sappiamo quando la vita deciderà di rivelare il proprio senso come un bene. La poesia finisce con questi versi:
Hanno aspettato per tutta la vita / il privilegio di essere stupide / le ragazze che ridono nel mare.
Queste piccole serissime bambine mi guardano come se avessi dato loro un portafortuna.
L’artista stampatore Giovanni Turria ha ideato le plaquette Monodose: piccoli cartigli colorati alti non più di cinque centimetri, racchiudono una sola poesia stampata a mano in minuscoli caratteri che si possono accarezzare con le dita, impressa sulla carta sottile di diversi colori e consistenze. Per il nostro secondo incontro scelgo i testi più adatti e preparo tanti piccoli mazzetti di Monodose. Quando tutte sono sedute apro la scatolina che ho posato chiusa sul tavolo, e comincio a passare a D. i mazzetti di poesie da distribuire. Hanno davvero la consistenza di una sorpresa nelle loro mani, le stringono come figurine preziose. «Sono così piccole! Non sono bellissime le cose piccole?». Non era solo il gusto di un piccolo regalo. Erano belle da toccare, muovevano i sensi, e soprattutto erano veicolate dalla bellezza delle cose piccole, da una misura che loro cercavano.
Avevo scelto una poesia di Antonio Riccardi che dice:
Le bambine rimaste molto da sole/ da grandi sono donne irresistibili./ Così sono le sirene.
Credevo che questi versi le avrebbero colpite più degli altri, non è stato così: mentre dicevo che loro in fondo erano sirenette, restavano impassibili. Non era essere irresistibili ciò che volevano, loro non volevano essere le sirene, volevano forse piuttosto essere le bambine: essere il più a lungo possibile le bambine che non restano da sole.
Abbiamo chiesto di leggere le poesie in silenzio e a ognuna di scegliere quella che la colpiva di più per leggerla a voce alta.
All’inizio parlavano a malapena, Le., tredici anni, stava seduta abbracciandosi le ginocchia e ci sorrideva timida se le chiedevamo qualcosa; tra noi ci dicevamo che sentire la sua voce sarebbe stato il nostro miracolo. Le. aveva scelto la sua poesia preferita, ma lo aveva fatto semplicemente porgendola a G. perché la leggesse. G., diciassette anni, era la più sicura, quella che aveva letto a voce alta per prima e a cui quasi tutte avrebbero chiesto di leggere al posto loro, anche le più spigliate come D. Sceglievano la loro Monodose, indicavano i versi che le avevano colpite, ma leggerla a voce alta era esporsi troppo. L’unica a non voler scegliere era stata C., undici anni, per tutto il tempo era rimasta in piedi contro la parete, non voleva sedersi, restava là con il suo carrello per la flebo e non parlava. Le Monodose le aveva accettate, le aveva guardate un po’, ma aveva risposto solo alzando le spalle.
Quasi tutte le ragazze dichiarano una preferenza per una poesia mia, segno che la lezione precedente ha creato un legame, ma è anche indicativo che fosse una poesia che parla di un abbraccio incompiuto. E dicono che se ci sei anche tu/ sembro meno nervosa/ è che mi togli i nervi e te ne vai [...] E se mi abbracci è come entrare in casa/ sapendo che non ci si può restare.
Questa preferenza rispetto alla poesia sulle sirene, mette in luce il concentrarsi su una relazione più che sull’idea dolorosa della bellezza: le bambine puntavano la propria attenzione non sul problema, ma sulla radice del problema. Un altro testo che le attrae è questo, della giovane poetessa Alessandra Frison: Mi lascerò diluviare/ oggi sulla strada fino a casa/ fino al pasto che aspetta/ come ogni sera le sue bocche/ quello che si chiama vita/ è riconoscersi piano/ dentro i soliti conti/ dentro le tasche o/ i corridoi strappati dalle facce. Le ragazze sono attratte principalmente dall’uso del verbo, l’idea del lasciarsi diluviare evoca l’idea del disciogliersi, un’immagine che presto loro stesse riprodurranno nella variante rovesciata dello sgretolarsi per siccità.
Quando chiediamo se abbiano mai scritto, ci dicono che per il laboratorio di musica hanno scritto una canzone in inglese. Proponiamo di tradurla, sarà il nostro primo passo per avvicinare la poesia. La canzone dovrebbe essere dedicata all’amicizia, è un solare inno alla vita, ne tradurremo soltanto tre versi prima di iniziare a entrare nella giungla delle immagini e andare in altre direzioni. Per ogni verso in inglese chiediamo alle ragazze di suggerire diverse traduzioni, dimostriamo che le parole si possono scegliere creando diverse sfumature anche minime; il primo verso non solleva problemi, mentre sul secondo inizia a svelarsi qualcosa. La traduzione letterale è “ridere finché non fa male”, M., diciassette anni, propone la variante “Ridere fino a farti male”. «Sarebbe quasi il contrario – diciamo noi – ridere fino a farti male è una risata che nasconde altro, una falsa risata». Proponiamo allora di fare una traduzione e il suo contrario, per ogni verso chiederci quale sarebbe il suo opposto usando la parola come, dicendolo con delle immagini.
Ballare fino all’alba/ ridere fino a che non ti fa male/ riconoscersi nel tuo sguardo. Non tradurremo mai oltre questi primi tre versi, il loro contrario riempirà l’intera ora e darà il via al laboratorio vero e proprio. Per dire il contrario di ballare fino all’alba le ragazze non dicono andare a letto presto, dicono stare soli in un angolo, stare sedute sul vuoto, ognuna completa e varia l’immagine dell’altra; il vuoto è l’elemento che condividono. Chiediamo di dirlo con più precisione, di far sentire che tipo di vuoto sia: scelgono con consapevolezza di attribuire al vuoto l’azione dello stancare, sono tutte d’accordo, stanno già raccontando il loro disturbo.
Il contrario del vago ballare fino all’alba per loro è stare in un angolo tra la folla/ abbassare lo sguardo nel vuoto/ che arriva fino a stancarti. Il contrario di riconoscersi nel tuo sguardo? «Affogare mentre nessuno guarda» dice D., ferma come una pietra. Questa bambina incredibile passava dal gioco alle immagini più dure, dalla leggerezza al senso del tragico. Quella metaforizzazione, che nei ragazzi del laboratorio a scuola va stimolata con la concentrazione, l’ascolto e un esercizio di attenzione alla realtà, in molte di loro è quasi un riflesso spontaneo; nell’attenzione estrema alle cose che l’anoressia mette in atto, anche il linguaggio perde istintività, si fa elaborato, scelto, il pensiero metaforico si compie in un’immagine-gesto, senza astrazioni. «Precipitare nel mezzo della partita» dice S. (diciassette anni), il contrario di riconoscersi nello sguardo dell’altro lo trasforma in qualcosa che non è appena un’immagine della non corrispondenza, è un’allegoria di un solo verso: dice nel mancare dello sguardo la caduta fisica, l’imbarazzo del ridicolo, il senso di fallimento.
Per rovesciare Ridere finché non ti fa male S. propone Piangere come un fiume che rompe gli argini. F. invece dice Piangere dentro, fino a sgretolarsi. S. piange forte e si vede come un fiume che straripa e distrugge una diga, F. piange senza lacrime e si sente come un vaso di terra cotta al sole, che si sgretola appena lo tocchi. Spiegano con questi dettagli la qualità del loro pianto, senza dire direttamente che è il loro modo di piangere. «Forse sono due attitudini – dico io – come chi si arrabbia, sbraita e poi subito gli passa e chi invece si offende e tiene il muso… Chi piange come rompere gli argini alzi la mano!» Solo S. alza la mano. «Chi si sgretola piano?» Otto piccole mani alzate. E mi accorgo che nella metafora del pianto hanno raccontato anche il loro sintomo. Le due diverse lotte con il vuoto: il cibo come una piena che rompe gli argini o come una siccità che prosciuga.
Mentre ce ne andiamo S. mi rincorre nel corridoio, mi chiede se ho altre Monodose per una ragazza che non si alza dal letto. Mi è capitato ancora di vedere le Monodose passate di mano in mano come una medicina: le poesie preferite sacrificate per regalarle a qualcuno.
A partire da una poesia di Emily Dickinson propongo il gioco Che animale sono, che animale sei. Ognuno di noi deve dire con quale animale si identifica e perché, il gruppo deve dire a quale animale invece lo vede somigliante. Il primo istinto metaforico è animale, lo si vede nei bambini e negli adulti. Inoffensivi ma rivelatori, gli animali ci portano in silenzio nel territorio delle somiglianze, quello in cui non ci scontriamo con la durezza dello specchio ma con la tenerezza della fiaba. Eppure ogni volta che scegliamo un animale ne evochiamo inconsciamente anche un’altro. Come in questo gioco, ciò che vediamo di noi stessi si scontra con lo sguardo che gli altri ci hanno posato addosso.
Da questo gioco passiamo a Io sono come. Chiediamo alle ragazze di raccontarsi con un’immagine, io sono come una porta aperta dal vento dice Valerio Grutt, io sono come un sasso levigato dal mare dico io. Non stiamo facendo meno sul serio, stiamo solo spostando la consapevolezza delle immagini, giocando con leggerezza iniziamo a dire «Io».
Le ragazze faticano ad abbandonare il perimetro delle metafore animali, e compare improvvisamente la figura mitologica dell’unicorno.
L’animale immaginario vive nell’inconscio da tremila anni, appare quasi come metafora di guarigione: il potere attribuito al suo corno è preservare dai veleni e curare. Velocissimo, selvaggio e fortissimo, si fa avvicinare e domare solo dalle fanciulle pure, le ama al punto da lasciarsi addomesticare, per loro resta volontariamente in un recinto. Così è ritratto nelle pitture rinascimentali, tra le braccia di una ragazza o rinchiuso in un recinto che potrebbe scavalcare con un salto. Nella visione cristiana, catturato e ucciso, rinasce in cattività, è l’emblema di Cristo che muore trasformando una divinità irosa in una amorevole. Alla fine della lezione G. ci dice che durante la settimana ha scritto, ci legge la sua poesia, anche S. ha scritto. Il laboratorio ormai è iniziato.
«Venerdì mi dimettono, e in questi giorni volevo scrivere una cosa ma non sapevo come dirla. Volevo dire che ho capito che il problema non è mangiare o non mangiare, quella è la cosa su cui sposto i pensieri per non pensare ad altro». Sono tutte d’accordo.
Chiedo se hanno mai pensato a questo spostare le cose, se conoscono il nodo profondo che sta dietro alla reazione. S. dice che quando va scuola la prendono in giro, a casa per non pensare a questo pensa al cibo. Chiedo di dirlo con le immagini, «mi sento come un giocattolo rotto» dice I. (dodici anni) «come un joystick che non funziona, i miei genitori non mi lasciano decidere niente». Chiedo se a questa cosa abbiano mai dato un nome. «Io la chiamo la voce» dice D., «perché sibila sempre, è come una sirena cattiva che ti vuole portare in fondo al mare». D. riprende l’immagine dell’affogare che già aveva usato alcune lezioni prima, e l’immagine del sentirsi come sott’acqua è condivisa da tutte.
Ora comprendo la freddezza che avevano mostrato verso l’immagine della sirena, che simboleggia ai loro occhi il proprio demone; prima attraente e rassicurante, poi giudicante come un carceriere: una strega che proprio come nella Sirenetta di Andersen le porta con l’inganno a stringere un pericoloso patto che non si scioglie. Forse loro non conoscono la fiaba originale, ma della Sirenetta incarnano l’elemento ossessivo, il desiderio di felicità patteggiato con una rinuncia, il prezzo di un doloroso e infinito movimento. In straordinario contatto con la natura simbolica del mito greco, la Sirena che vedono è anche pura voce: il mostro primitivo che dirotta la mente e affonda le navi, il canto ossessivo che separa da noi stessi e porta l’anima fuori dai bordi. Nelle sirene irresistibili le bambine vedono la bellezza cattiva, forse anche una rappresentazione negativa e negata della sensualità: «è come un’amica che prima sembra buona, ma poi ti accorgi che è cattiva, e quando lei si accorge che lo hai capito e cerchi di allontanarti si arrabbia, diventa ancora più cattiva, e ti dice continuamente cose cattive nelle orecchie» aggiunge D. Tutte le ragazze concordano con questa immagine. Mettiamo le nuove immagini in versi di seguito alla traduzione. Dico loro che conoscere il proprio “mostro” permette di riconoscerne le mosse, anticiparle, depotenziarle, e che scoprire il perché delle cose è il più grande passo per guarire.
D. dice che presto uscirà e che ha paura: «Ho pensato che qui mi sento al sicuro ma non sono libera, è come una gabbia d’oro. Perciò voglio uscire, ma ho paura di ricominciare a stare male quando non sarò protetta da questo posto.»
Dico loro che la scrittura d’ora in poi sarà come un amuleto e un’arma, che quando l’ossessione prenderà il sopravvento, scrivendo la poseranno sul foglio, accenderanno la luce sul mostro nell’armadio e metteranno la belva in una gabbia. Potranno guardarla negli occhi, toccarla, imparare a dominarla: diventerà la loro belva.
Dopo questo incontro veniamo contattati dalla responsabile dei volontari, ci dice che le ragazze hanno parlato agli psicologi delle cose dette durante il laboratorio, allarmata ci chiede di cambiare discorso se le ragazze dovessero affrontare di nuovo l’argomento del disturbo in modo diretto; ci dice che è regola dei volontari non accennare mai all’argomento né al cibo.
Una delle ragazze, uscita prima della fine dell’incontro, aveva manifestato in seguito fastidio per le cose che le altre dicevano – una reazione che mi era sfuggita, perché a causa dell’iperattività le ragazze si alzavano più volte durante l’incontro, uscendo e rientrando dalla stanza senza mai chiederlo o motivarlo. Scopro inoltre che D. ha espresso alla psicologa la sua paura di uscire, elaborando esattamente lo stesso concetto della prigione felice espresso durante l’incontro e messo in versi anche da G. in una sua poesia; mentre la stessa G. e in particolare I., hanno parlato di questa lezione manifestando spiccato entusiasmo. Scopro anche che è stata questa la prima volta in cui le ragazze hanno parlato spontaneamente del proprio disturbo con qualcuno che non fosse lo psicologo, nonostante nel reparto si tengano attività quasi quotidiane e la presenza dei volontari sia costante.
Valerio Grutt, in qualità di responsabile del progetto, viene contattato direttamente dal primario, che ci consiglia di non sviare il discorso quando i ragazzi stessi vogliono affrontarlo, tenendo presente che incontriamo ragazzi che hanno diversi livelli di consapevolezza nell’affrontare il percorso di guarigione. Da questo momento gli specializzandi di psicologia assistono alle nostre lezioni.
La settimana successiva io e Valerio, inizialmente, non sappiamo come riprendere il lavoro senza arretrare sul risultato raggiunto. Vogliamo portare il laboratorio su un livello di maggiore leggerezza, ma senza che le ragazze la vivano come una nostra mancata responsabilità rispetto a ciò che ci hanno affidato. Nel territorio del laboratorio si entra sempre con una leggerezza iniziale, con qualche chiacchiera apparentemente frivola, questo ci viene in aiuto. Qualcuno chiede «di che segno sei?», lo chiediamo a tutte, inizio a spiegare la divisione per elementi e arriva l’intuizione: scrivere dando voce al proprio elemento. Così le dividiamo in due gruppi, per elementi opposti: l’acqua insieme alla terra, il fuoco insieme all’aria. Sperimentiamo due approcci diversi: i segni d’aria e di fuoco insieme a Valerio scrivono un testo collettivo sull’aria e uno sul fuoco, io invece chiedo ai ragazzi di terra che cosa dica la terra e a quelli d’acqua che cosa dica l’acqua, chiedo di farle parlare dicendo io. Io sono la terra e... «Fiorisco anche dopo/ essere stata calpestata.» dice F. (quindici anni), «sono un albero con un pensiero nuovo in ogni ramo» aggiunge L. (tredici anni).
L’acqua per D. dice: «Tutti dicono che sono azzurra/ ma se mi prendi in mano traspaio», e per la prima volta Le. (13 anni), dando voce al suo elemento d’acqua parla: «Posso essere calma piatta/ o avere la forza di una tempesta.». Lo dice pianissimo, e mentre le parole per Le. iniziano ad arrivare, L. ha preso a scrivere e continua per conto suo: Sono come il cuore di una montagna/ antica e saggia, che aspetta/ il suo contadino/ che la guida come un padre. Le. pensa in silenzio, scrive, poi mi chiama per nome e come se ci fossimo solo io e lei mi legge Dell’acqua sono il contrasto./ Non sono mai mite./ Per me non esiste/ una via di mezzo./ Perché sono fin troppo/ calma o fin troppo tempestosa. Le chiedo di renderlo ancora più preciso, di aggiungere una metafora finale, di avvicinare a qualcos’altro questo essere fin troppo calma o troppo tempestosa. Ci pensa e poi aggiunge un verso: come una notizia inaspettata. D. dice che da piccola pensava che l’acqua del mare fosse salata perché c’erano dentro le lacrime degli squali. Ci fa sorridere, diciamo che è bellissimo, ne fa l’inizio della sua poesia. Ma questo incipit apparentemente giocoso e infantile in seguito verrà tolto dalla poesia. D., tornata a casa dopo essere stata dimessa, ci manderà la poesia che aveva chiesto di tenere per ricordo, ma senza più quell’immagine iniziale. I versi seguenti dicono: Nessuno può toccare il fondo del mare/ perché è come toccare il fondo di una persona,/se ci riesci senti male,/ un dolore indescrivibile.
Alla fine della lezione I. e M. vengono da me, vogliono farmi leggere quello che hanno scritto. M. ha scritto quello che le succede in una poesia per la madre, l’immagine ricorrente e il rallentare del cuore, il fissare il vuoto, le lacrime che non scendono, poi D’un tratto uno sguardo illumina/ il mio buio,/ si fa vicino fino a scomparire nel mio. Parla dell’abbraccio materno e dice cinge il mio esile corpo/ che al suo interno quasi scompare. I., durante la settimana, ha messo in versi ciò che diceva nell’incontro precedente, ma lo rovescia: Io sono un gioco/ che non rispetta i comandi,/ che vuole essere libero/ di fare ciò che vuole. Un testo che si chiude così: dentro sappiamo quello che vogliamo,/ la cosa che non sappiamo/ è come farlo uscire,/ come poterci mostrare al cielo aperto. Versi che rappresentano bene anche il risultato e il compito del laboratorio di poesia.
Nell’incontro seguente le ragazze ormai ci leggono i propri testi a voce alta, Le. mi mostra il cellulare e mi fa leggere una piccola poesia d’amore. Questa volta chiedo di scrivere l’opposto del proprio elemento, come un completarsi. Per farlo i ragazzi pensano a qualcuno che li completi e al modo in cui loro stessi possono completare qualcuno. Le. scrive, poi mi legge questa poesia:
Mi perfezioni gli errori
li fai giusti.
Assorbendomi mi rinforzi.
Siamo come bambini che giocano. Siamo la riva.
Ci scontriamo come pioggia sull’asfalto.
Siamo come il contrasto dell’arcobaleno.
Boom: ci completiamo all’improvviso.
Anche C. aveva smesso di stare alla parete in silenzio, non aveva voluto firmare la poesia sul fuoco, ma questa volta firmerà anche lei quella sull’aria. E., per tutto il tempo, ha disegnato un unicorno che vomita arcobaleni.
L’arcobaleno è un altro simbolo che ricorre: il ponte tra visibile e invisibile, il patto tra cielo e terra: elementi diversi che fondendosi creano un miracolo. Come nei versi di Le. è un simbolo di rinnovamento del cuore. Valerio dice che potrebbe essere la copertina di un libretto, chiede alle ragazze se sarebbero felici di raccogliere in un libro tutti i testi che hanno scritto. La loro risposta è unanimemente sì.
Durante l’ultimo incontro recuperiamo i testi scritti dai quaderni e dai telefoni, decidiamo come organizzarli: la traduzione in apertura, una sezione con i testi dedicati agli elementi, una con le poesie scritte liberamente.
Dobbiamo trovare un titolo, le ragazze vogliono che si rifaccia al gioco degli animali. F. propone L’animale dall’altra parte, sarà il nostro titolo. Il secondo titolo in classifica è L’altra faccia dell’arcobaleno, scegliamo di usarlo per la sezione di poesie scritte autonomamente dalle ragazze: l’altra faccia dell’arcobaleno è il temporale da cui l’arcobaleno nascerà. F.A.T.A Fuoco, acqua, terra, aria, è il titolo che diamo alla sezione con le poesie dedicate agli elementi; un altro simbolo compare solo alla fine, non più la strega o la sirena, ma il suo rovescio positivo terrestre e aereo, la fata come emblema protettivo.
Chiediamo loro che cosa gli sia piaciuto di più del laboratorio. «Quando abbiamo parlato apertamente della nostra malattia» dicono I. , F. e Le. Chiediamo cosa pensano di questa esperienza, con parole diverse dicono tutti la stessa cosa: mi è piaciuto ed è stato importante perché sono riuscita a dare forma e a dire cose che non sapevo dire.
Vogliono stampare quello che hanno scritto, vogliono che quel libretto resti nel reparto per le ragazze che lo attraverseranno quando loro saranno tornate a casa.
L’animale ormai è dall’altra parte, non fa più paura. Questa idea della doppiezza e del rovesciare il punto di vista accompagna il percorso che abbiamo fatto: parte dal trovare il contrario della traduzione e arriva al riconciliarsi degli elementi opposti, nell’altra faccia di un arcobaleno che è completarsi improvviso. Non è stato all’improvviso, l’animale che era dall’altra parte di noi è venuto allo scoperto, come l’unicorno si è lasciato toccare, e adesso non fa più paura, lo guardiamo da un’altra prospettiva. Il fatto che desiderassero pubblicare ciò che avevano scritto era l’ultimo passaggio del laboratorio, la prova che avesse funzionato. Nella pubblicazione, similmente al momento in cui in un’analisi il trauma viene detto a voce alta, c’è una liberazione che si compie. Il dolore si trasforma in bene, si stacca dal ramo come un frutto.
 Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978, ha pubblicato i libri di poesia La coinquilina scalza (Niebo/La vita felice, 2004) edito anche in Spagna, Una stagione d’aria (Donzelli, 2017) e il saggio Domare il drago (Mondadori, 2018), metodo con cui tiene workshop e laboratori di poesia in tutta Italia. Ha fondato e dirige il Festival Parco Poesia.
Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978, ha pubblicato i libri di poesia La coinquilina scalza (Niebo/La vita felice, 2004) edito anche in Spagna, Una stagione d’aria (Donzelli, 2017) e il saggio Domare il drago (Mondadori, 2018), metodo con cui tiene workshop e laboratori di poesia in tutta Italia. Ha fondato e dirige il Festival Parco Poesia.
» La sua scheda personale.